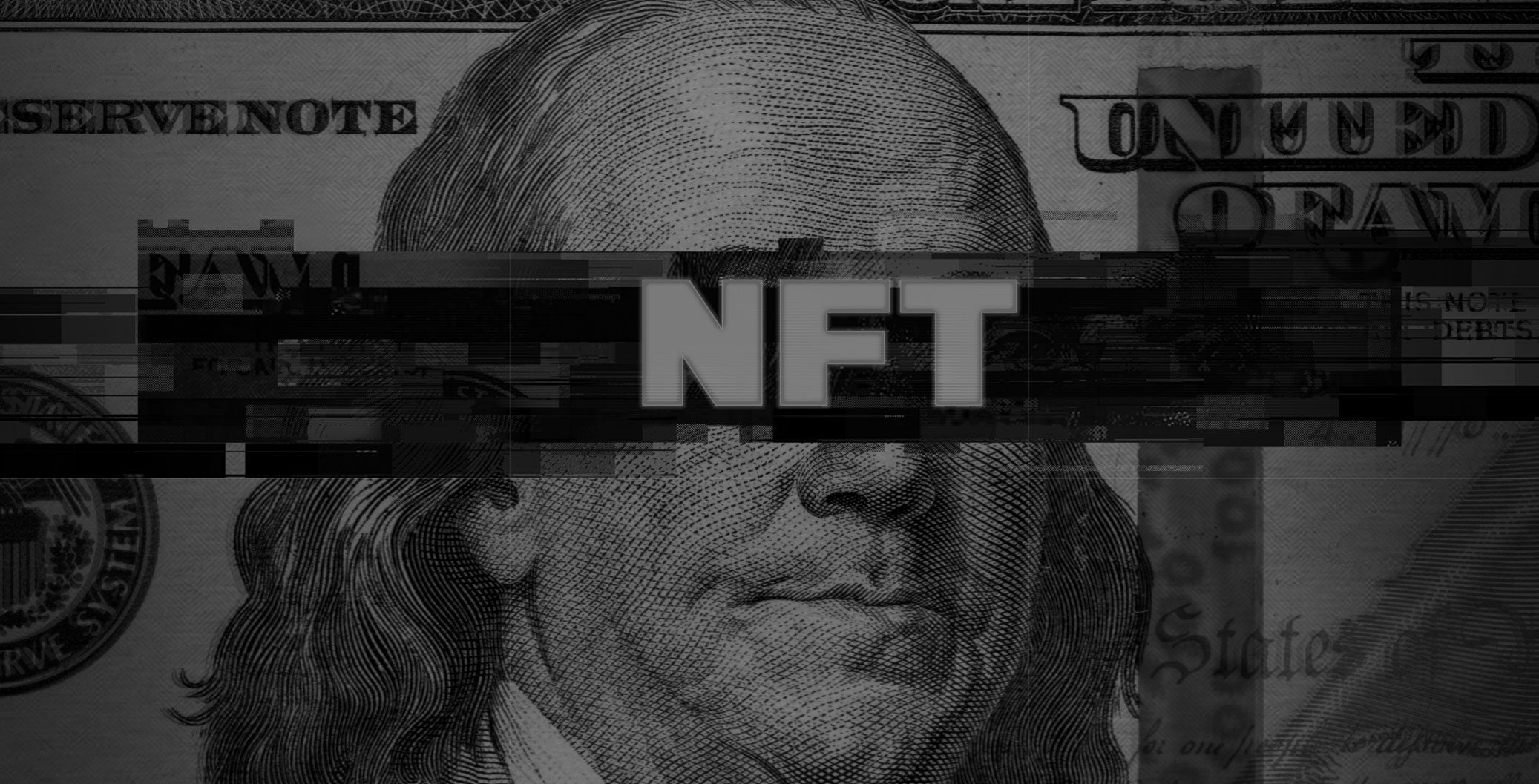Il 2022 potrebbe rilevarsi come un anno significativo per accrescere (ancora di più) l’interesse sul mondo del metaverso e della tokenizzazione, nonché in particolare sui cd. NFT – Non Fungible Token.
Tali concetti – al di là delle terminologie usate – non risultano di facile comprensione, soprattutto perché consistono nella traslazione del mondo reale in un vero e proprio universo digitale, poco conosciuto così come poco regolamentato. Infatti, il termine metaverso[1] indica un mondo digitale in 3D che accoglie ogni tipo di esperienza e all’interno del quale, per il mezzo del proprio avatar, possono aver luogo diverse nostre attività quotidiane svolte tipicamente nel modo reale, come assistere ai concerti, andare al cinema, visitare musei, incontrare persone, fare acquisti in un centro commerciale.
Tale mondo è strettamente collegato al fenomeno della tokenizzazione e in particolare ai cd. NFT “Non Fungible Token”, ossia risorse virtuali (token) unici (non fungibili) create generalmente per rappresentare asset in formato digitale (opere d’arte digitali, oggetti collezionabili su blockchain, proprietà nel mondo virtuale) o per certificare proprietà fisiche reali su determinati beni (auto, opere d’arte, immobili…)[2], agevolmente scambiabili – tramite piattaforme dedicate – su blockchain (i.e. un registro che contiene lo storico delle transazioni effettuate tra le parti)[3].
In altri termini, si tratta di asset digitali generati su catene di blocco (blockchain) che permettono di identificare in modo unico un oggetto digitale o un diritto relativo a un bene fisico e, inoltre, di garantirne la titolarità sullo stesso. Attraverso gli NFT, infatti, si può acquistare un diritto di proprietà su qualsiasi bene unico, come un atto per un oggetto nel regno digitale o fisico[4].
A testimonianza del forte clamore e del notevole impatto che tali eventi stanno generando (e che probabilmente continueranno a generare) sull’economia mondiale rilevano i numerosi e considerevoli investimenti che le grandi multinazionali stanno effettuando nell’ambito dell’universo digitale e degli NFT. In particolare, si registra come i maggiori utilizzi di tali token si sono attualmente verificati nei più svariati settori quali l’arte, lo sport, la musica, l’editoria, la moda e molti altri: si segnala, infatti, come di recente Coca-Cola ha venduto la versione NFT di alcuni oggetti vintage, mentre Dolce & Gabbana ha creato una collezione di abiti e gioielli fisici corredati dai corrispondenti NFT, così come anche Boeing ha espresso la volontà di entrare nel mondo del metaverso per confermarsi tra i colossi del settore aerospaziale [5].
Ma l’elemento che giustifica maggiormente il recente boom che i token infungibili hanno riscosso in tutto il mondo sembra essere rappresentato dal vasto pubblico di investitori coinvolti in quanto la creazione, l’acquisto, la vendita e lo scambio (per finalità di investimento) di un NFT non risulterebbe esclusivo per le sole persone abbienti.
Tuttavia, pur essendo rappresentato come il mondo del futuro, si evidenzia come, ad oggi, tale “universo” risulti di difficile comprensione per l’investitore, non soltanto per la complicata terminologia usata ma soprattutto per l’attuale assenza di un adeguato inquadramento giuridico e di una disciplina fiscale ad hoc.
Quanto premesso, il presente scritto è finalizzato a fungere da vademecum per analizzare – allo stato attuale – la disciplina giuridica e tributaria riservata agli NFT.
Per una più agevole lettura, il testo completo è disponibile al link di seguito.